
Tempi num.6 del 08/02/2007

Cultura L'OMAGGIO DI BARI AL SUO PATRONO
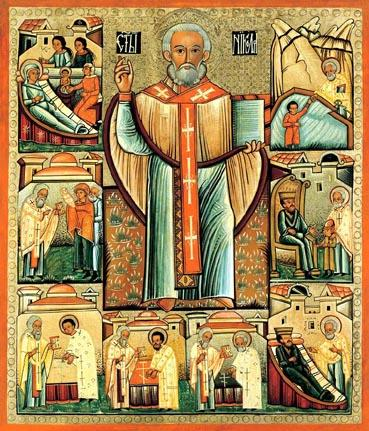
Era morto e sepolto, ma il suo corpo continuava a
profumare. Anzi, a trasudare profumo. Una strana sostanza oleosa e fragrante
bagnava la pietra del sepolcro. Ben presto i custodi scoprirono che l'unguento,
intinto in una spugna e distribuito ai pellegrini, guariva corpi zoppi e
paralitici, rinsaldava spiriti affranti. Ma diluito in acqua e versato in
boccette di alabastro era il segno che la sua morte non era stata la sua fine,
anzi, teneva unito un popolo lasciato orfano del suo vescovo. Il suo santo myron
attirava sempre più devoti e curiosi, ai quali Nicola non chiedeva di essere
contemplato con gli occhi della fede, ma incontrato con tutti i sensi, primo fra
tutti l'olfatto. Il corpo e l'immagine di Nicola vescovo di Myra (più noto come
san Nicola di Bari da quando, nel 1087, sessantadue marinai baresi trafugarono
le reliquie da Myra portandole nella città pugliese) sono messi a tema nella
spettacolare mostra storico-artistica in corso fino al 6 maggio nel Castello
Svevo di Bari. San Nicola. Splendori d'arte tra Oriente e Occidente, a cura di
Michele Bacci, è un viaggio in sette tappe, attraverso la secolare tradizione
iconografica del santo: le origini in Asia Minore, la diffusione nel mondo
bizantino e in Russia, l'arrivo delle spoglie a Bari e a Venezia, la fortuna
delle immagini nel mondo occidentale e il mito del portatore di doni. Oltre 120
capolavori dal Medioevo a Andy Warhol - reperti archeologici, monete, dipinti,
oreficerie e arredi liturgici - testimoniano il destino di Nicola, santo
universale e transconfessionale, capace di suscitare la devozione di migliaia di
fedeli e di adattarsi a tradizioni, contesti e funzioni anche molto diversi tra
loro. Ideale ponte di fede e di comunione tra le Chiese cristiane d'Oriente e
d'Occidente, san Nicola è raffigurato nelle icone ortodosse di Andréas Ritsos,
ma anche nei bassorilievi delle cattedrali europee; è presente negli affreschi
della chiesa di Santa Sofia a Kiev, ma anche nelle tele di Tiziano e Tiepolo, o
nelle predelle con episodi della vita e dei miracoli dipinte da Agnolo Gaddi in
Santa Croce a Firenze.
Nato in Licia (l'attuale Turchia), vissuto al tempo dell'imperatore Costantino,
fin da ragazzo Nicola aveva preso sul serio l'insegnamento di Cristo, spendendo
la sua esistenza a servire l'essere umano senza distinzione di razza, di
religione e di cultura. Osteggiato dagli ambienti religiosi, inquinati di
arianesimo, ma ben voluto dalla gente comune che ne apprezzava la generosità e
il senso di giustizia, era stato acclamato vescovo a furor di popolo dagli
abitanti di Myra, una cittadina dell'Asia Minore (odierna Demre) che viveva di
pastorizia e di scambi commerciali tra il Mar Nero a nord e il Mar di Levante a
sud.
Era cresciuto senza una specifica formazione ecclesiastica, non aveva una
spiccata sapienza teologica (non tutte le fonti lo ricordano, ma se mai
partecipò al Concilio di Nicea del 325 non ebbe un ruolo preminente); morì nel
343 circa, non si sa se martirizzato oppure no. Che cosa, allora, ne fece un
santo? Fu semplicemente l'amore, quella premurosa, affettuosa e carnale carità
che spingeva Nicola a rispondere con un gesto concreto al bisogno dell'altro.
Mentre Myra è minacciata da una grave carestia, approdano al porto di Andriake
alcune navi cariche di grano, provenienti da Alessandria d'Egitto e dirette a
Costantinopoli. Nicola, vescovo della città, convince l'equipaggio a scaricare
cento moggi per sfamare la sua gente e si impegna personalmente a garantire
l'impunità dei marinai. Giunti a destinazione, i mercanti pesano la merce e si
accorgono che la quantità di grano corrisponde esattamente a quella imbarcata ad
Alessandria. Ben mille anni prima del leggendario bandito inglese Robin Hood,
san Nicola di Myra rubava ai ricchi per dare ai poveri e difendeva i deboli dai
soprusi dei potenti. Lo racconta Michele Archimandrita all'inizio dell'VIII
secolo nella Vita di San Nicola (una delle biografie più antiche e complete), lo
dipinge a tempera su legno nel XV secolo il Beato Angelico, su una tavoletta
esposta in mostra e che illustra, come in un fumetto a due tempi, il Miracolo
del grano.
Ma non finisce qui. Le truppe comandate dai generali Nepoziano, Urso ed
Erpilione sostano a Myra durante una spedizione mossa a sedare una ribellione in
Frigia. La presenza dei soldati in città crea risse e tumulti e, nel caos che ne
deriva, il corrotto governatore Eustazio acconsente - dietro lauta ricompensa -
a condannare a morte i tre generali innocenti. L'esecuzione è fermata da Nicola
in persona. Tuttavia, al loro ritorno a Costantinopoli, i tre generali che hanno
sedato la rivolta e sono accolti come trionfatori, suscitano la gelosia del
prefetto Ablabio che, sostenuto dalle milizie imperiali, organizza un complotto
ai loro danni. Imprigionati e condannati a morte senza processo, i tre soldati
si ricordano del vescovo di Myra e della sua giustizia e ne implorano l'aiuto.
Nicola nottetempo appare in sogno sia al prefetto sia all'imperatore e li
minaccia di terribili punizioni se non renderanno giustizia ai tre stratilati
innocenti. Questi, appena liberati, si recano a Myra per dire grazie al loro
protettore, un gesto umano e bello, immortalato nel 1746 dal pittore pugliese
Corrado Giaquinto nel quadro in mostra.
Tre doti per tre figliole
Il fascino di Nicola è alimentato dal mistero delle sue origini: una fisionomia
storica ancora più complicata dal fatto che, nella letteratura agiografica, egli
subì una contaminazione con un altro illustre Nicola, monaco del VI secolo
vissuto nella stessa zona dell'Asia Minore, abate del monastero di Sion e
vescovo di Pinara. Un fascino ricco di enigmi, ma alimentato dalla concretezza
di un fortissimo culto, destinato ad espandersi da Myra in tutto il
Mediterraneo.
Poco o nulla si conosce della famiglia di Nicola, di come fu la sua infanzia.
Rimasto orfano di genitori ricchi, aiuta economicamente un povero padre di
famiglia impedendogli di prostituire le tre figliole. Questo gesto di carità
passerà alla storia come il Miracolo delle tre fanciulle, magistralmente
rappresentato in mostra dal dipinto di Sebastian Dayg (1525) e sarà all'origine
dell'iconografia rinascimentale del vescovo Nicola che porta sempre in dono tre
palle d'oro, sorreggendole nella mano sinistra, come lo ritrae Antonio Vivarini
nel 1450. La storia sfuma nella leggenda e racconta di un nobiluomo di Patara
(forse città natale di Nicola) padre di tre ragazze in età da marito, alle quali
Nicola regala la dote di nascosto, gettando nella finestra di casa loro, per tre
notti consecutive, un sacco di monete d'oro. Alla terza notte il padre rimane
sveglio per scoprire che volto ha la provvidenza e, al tintinnio del denaro che
cade nella stanza, si precipita fuori per vedere il suo benefattore. Non appena
riconosce Nicola, però, il giovane gli intima di non rivelare l'accaduto.
Anche a noi piacerebbe conoscere il suo volto. L'unica icona che lo documentava
"come vivo", collocata almeno fino al 1362 nella basilica di San Nicola di Myra
e poi nella cattedrale latina di San Nicola a Famagosta, andò distrutta
verosimilmente durante l'assedio ottomano del 1571, quando l'edificio fu
trasformato nella moschea di Lala Mustafa. Ma la mostra ci consola, offrendoci
l'eccezionale presenza di otto antichi dipinti su tavola provenienti dal
Monastero di Santa Caterina al Monte Sinai, ritenute le più antiche icone
conosciute in onore del santo nonché le sue più antiche rappresentazioni
pittoriche. Abitualmente non accessibili al pubblico, i dipinti saranno
presentati oggi, giovedì 8 febbraio, al Castello Svevo alla presenza
dell'arcivescovo ortodosso del Sinai Damianos, abate di Santa Caterina, e di una
delegazione del ministero egiziano della Cultura. Un evento straordinario per la
più grande collezione di dipinti su tavola, databili tra il VII e il XIV secolo.
Caratterizzata da colori vivaci e da una composizione tardo-romana, ogni icona
permette di cogliere tutta la forza espressiva e l'impatto emozionale della più
raffinata arte di Bisanzio. Il dato storico si incrocia con la devozione, l'arte
con la bellezza, sulla scia di un santo che, da morto, non è mai stato così
vivo.
1. Il miracolo delle tre fanciulle
Il miracolo delle tre fanciulle fu dipinto da Sebastian Dayg verso il 1525 su
una piccola tavola di legno di conifera, con tempera mista a olio e a lacca.
Proviene dal Museo di Ulm e faceva parte di un polittico raffigurante tre o
quattro episodi della giovinezza di san Nicola, quando non era ancora vescovo.
Nella visione pittorica, tuttavia, il santo indossa già la veste episcopale e un
mantello rosso che crea un contrappunto cromatico con il colore della coperta
del letto dove dormono le sorelle e quello dell'abito del padre. Nel corso del
XVI secolo la devozione a san Nicola diventa forte in Europa occidentale, dove
si registrano oltre 2550 luoghi di culto a lui dedicati.
1525-30, tecnica mista su legno
di conifera, 56x63 cm, Ulm, Museo di Ulm
2. I tre stratilati rendono omaggio a san Nicola
L'omaggio dei tre stratilati a san Nicola fu dipinto da Corrado
Giaquinto in 4 versioni verso il 1746. Quella esposta a Bari proviene dal museo
di Stoccarda ed è il modello definitivo scelto per la pala d'altare della chiesa
di San Nicola dei Lorenesi di Roma. Capolavoro della pittura barocca
meridionale, raffigura il momento conclusivo dell'unico miracolo ricordato nel
Martyrologium Romanum, il più celebre compiuto in vita dal vescovo di Myra. Per
dipingere la tela (e il suo pendant con Nicola che salva i naufraghi dalla
tempesta) l'artista, in segno di devozione, si dimezzò il compenso, chiedendo
500 scudi anziché 1.000.
1746 circa, olio su tela, 137x97 cm, Stoccarda, Staatsgalerie
3. Miracolo del grano e san Nicola salva una nave nella tempesta
Il miracolo del grano è narrato dal Beato Angelico insieme a quello della
tempesta sedata. La tavoletta di legno dipinto a tempera proviene dalla
Pinacoteca vaticana e illustra il vescovo sul molo, mentre con mantello verde e
mitria bianca osserva le operazioni di scarico dei sacchi di grano; sullo sfondo
è dipinta una barca in balia della tempesta, sedata dal santo che appare nel
cielo come una saetta di luce. La predella appartiene a un polittico in parte
smembrato, commissionato verso il 1450 al pittore di Fiesole dalla famiglia
Guidalotti per decorare l'altare della cappella dedicata a san Nicola, nella
chiesa di San Domenico di Perugia.
Tempera su tavola, 34x60 cm, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana
4. San Nicola
Viene dal Seminario patriarcale di Venezia la tempera su tavola, impreziosita di
foglie d'oro, dipinta verso il 1450 da Antonio Vivarini. Faceva parte di un
polittico con figure di santi. Il culto di Nicola era forte a Venezia, dove
alcune sue reliquie si conservano dal 1100 nell'abbazia di San Nicolò di Lido.
Nelle acque antistanti si svolgeva lo "sposalizio del mare": il doge gettava in
laguna un anello e invocava la protezione di Nicola sulla flotta veneziana.
1450-51, tempera su tavola, 55,5x38 cm, Venezia, Seminario patriarcale
Marina Mojana

|

|

|

|